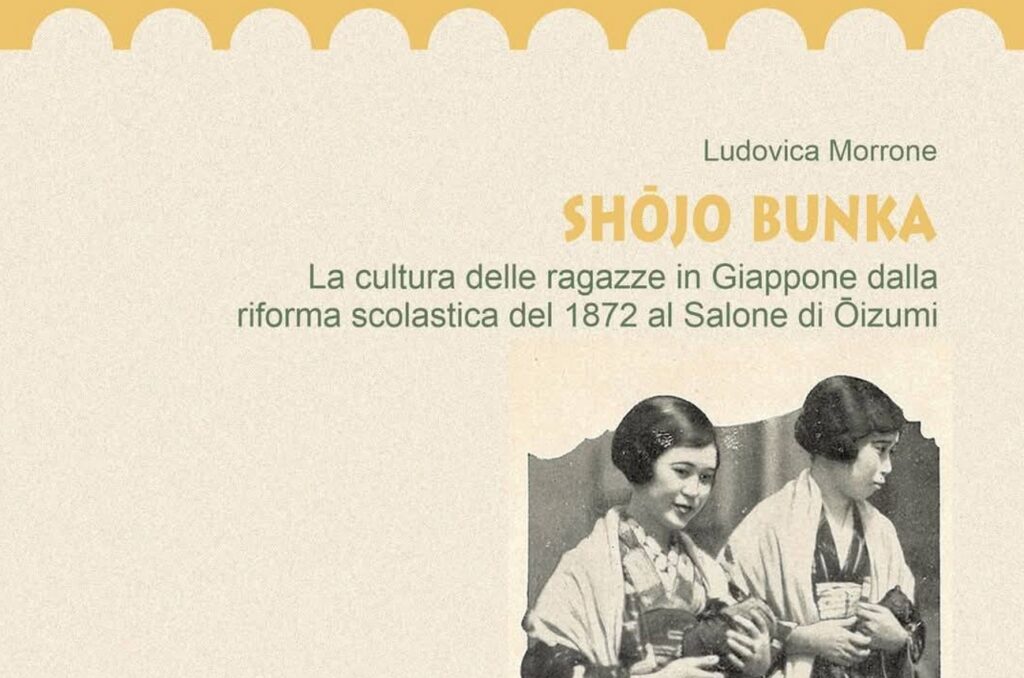Durante l’era Meiji (1868-1912) il governo giapponese abbondona il sistema feudale dello shogunato per aprirsi a un processo di riforme politiche, economiche e sociali in grado di proiettare il Giappone all’interno di un panorama di relazioni internazionali. Si tratta di un periodo emblematico, non solo per l’evoluzione e lo sviluppo dello Stato, ma anche per la nascita di un nuovo gruppo sociale: le shoujo.
Il termine shoujo si riferisce a un arco temporale specifico della crescita della bambina-ragazza e che comprende sia la fanciullezza che l’adolescenza. Questa nuova figura sociale porta alla luce in Giappone nuove esigenze e richieste specifiche proprio nei confronti di una presenza femminile sempre più presente e attiva nella società.
Nel 1872 viene approvata la Legge del sistema scolastico che invita le giovani giapponesi a frequentare la scuola e impone allo Stato di offrire alle nuove studentesse materiali e testi scolastici a loro dedicati. In questo modo lo Stato intende incoraggiare le donne ad apprendere e a istruirsi non solo per una questione morale, ma anche per impiegarle come forza lavoro nelle numerose industrie nascenti in tutto il Paese.
Pertanto, da quel momento le donne iniziarono a uscire dalle mura domestiche e ad abbandonare il vestiario casalingo, non più adatto a rispondere alla nuove esigenze femminili: le giovani giapponesi iniziano così a vestire abiti occidentali, a uscire, a studiare e a frequentare luoghi e attività a loro dedicate, trasformandosi poco per volta nel simbolo di un Giappone che intende percorrere un processo di ammodernamento e che guarda al futuro.
Certamente non va dimenticato che molto di questo cambiamento fu ispirato e influenzato dalla moda occidentale, ma anche dalla ricerca e dal desiderio di nuove forme di intrattenimento, che trovarono nell’editoria terreno fertile per la loro diffusione, soprattutto grazie a numerose riviste e manga.
Si tratta di un affascinante viaggio all’interno di una grande rivoluzione culturale quello raccontato da Ludovica Morrone nel suo libro Shoujo Bunka – La cultura delle ragazze in Giappone dalla riforma scolastica del 1872 al Salone di Oizumi, edito da La Società Editrice La Torre.
Laureata in Lingue e Civiltà Orientali presso l’Università di Roma “La Sapienza”, membro dell’Associazione Italiana per gli Studi Giapponesi e traduttrice freelance dal giapponese per alcune delle più importanti case editrici di manga in Italia, Ludovica Morrone racconta l’incredibile cambiamento sociale avvenuto in Giappone dal 1872 grazie alla riforma del sistema scolastico e all’istruzione femminile.
“Shojo Bunka” è un saggio fondamentale per chiunque voglia comprendere l’evoluzione del ruolo femminile in Giappone attraverso la lente della “cultura delle ragazze” (shoujo bunka). Il libro si presenta come un’analisi approfondita e ben documentata di come le riforme sociali, l’istruzione, la moda e i media abbiano plasmato l’identità delle giovani donne giapponesi dall’era Meiji fino agli anni ’70 del Novecento in un percorso di graduale emancipazione.
Il volume traccia un percorso storico-culturale complesso, partendo dalla riforma scolastica del 1872, che per la prima volta aprì le porte dell’istruzione formale alle ragazze, fino ad arrivare a momenti cruciali come il Salone di Oizumi, un evento iconico degli anni ’70 che simboleggia un’epoca di maggiore consapevolezza e autonomia femminile. Questo ampio arco temporale permette all’autrice di mostrare come la figura della “ragazza moderna” si sia progressivamente definita, passando da un ruolo prevalentemente domestico e tradizionale a una posizione via via più dinamica e influente nella società giapponese.
Il libro esplora inoltre con grande precisione i vari aspetti culturali che hanno contribuito a questa trasformazione: non si limita a descrivere i cambiamenti nelle politiche educative, ma analizza anche l’impatto della moda, della letteratura per ragazze (con un focus particolare sulle riviste shoujo), e dell’intrattenimento in generale, dal teatro al manga. La “shoujo” emerge non solo come una categoria anagrafica, ma come un fenomeno culturale che ha agito da motore per il cambiamento, influenzando le aspirazioni, i gusti e i comportamenti di intere generazioni.
Buona lettura!
*** Se trovi gli articoli, le traduzioni e le recensioni di questo sito utili, per favore sostienilo con una donazione. Grazie! ***
Se volete potete distribuire liberamente questo testo, in maniera non commerciale e gratuitamente, conservandone l’integrità, comprese queste note, i nomi degli autori ed il link http://sakuramagazine.com